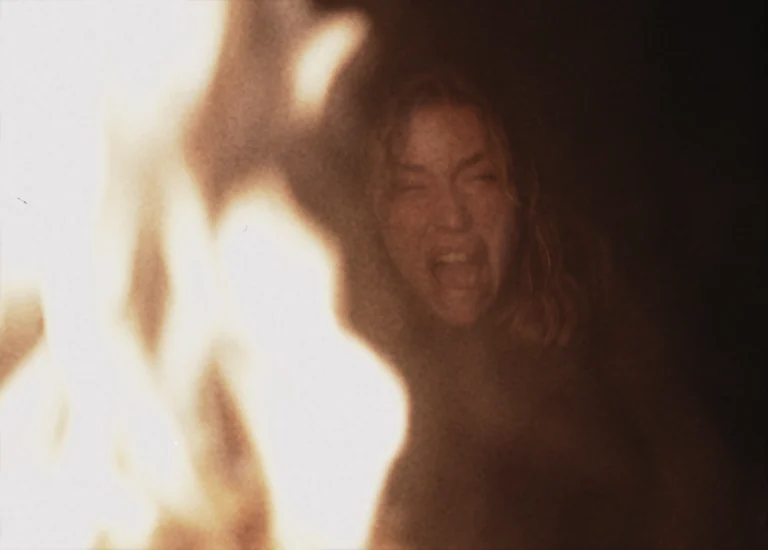Nota per il lettore:
Questo articolo non intende in alcun modo celebrare né legittimare l’ideologia fascista. Il suo obiettivo è analitico e culturale: comprendere come alcuni codici estetici nascano in un tempo e vengano poi rielaborati, criticati o assorbiti da sottoculture, moda e cinema. Vista la massiccia presenza di capi ispirati all’abbigliamento bellico nelle sfilate contemporanee, è importante contestualizzare storicamente l’origine dell’estetica fascista e dei suoi simboli. Questo è il primo di una serie di articoli: partire dall’inizio serve a disinnescare letture semplicistiche e stimolare una consapevolezza critica sul presente.
Quando l’uniforme diventa subcultura: gli squadristi
Il fascismo, prima ancora di diventare regime, fu una subcultura violenta.
Perché subcultura? Perché possedeva codici estetici propri, uno slang specifico, una ritualità di gruppo e una precisa attitudine giovanile. In tutto e per tutto, ciò che oggi definiremmo una “gang”.
A livello visivo, la vera innovazione degli squadristi fu l’uso dell’abbigliamento militare fuori dal suo contesto, attribuendogli un significato identitario, virile, minaccioso e insieme seduttivo.
Un’estetica di potere e intimidazione, che troverà poi nuove forme nelle sottoculture successive: i biker, i teddy boy, i punk, gli skinhead.

Contesto storico: l’Italia post-1918
600.000 morti e oltre un milione di feriti: così l’Italia uscì “vittoriosa” dalla Prima Guerra Mondiale.
Ma era una vittoria solo formale. L’economia era al collasso, l’inflazione esplosa, e sul piano territoriale si parlava già di “vittoria mutilata”. L’anima della nazione era ferita, spaccata.
È in questo vuoto sociale, politico e simbolico che nascono gli squadristi.
In chiave contemporanea, potremmo descriverli quasi come un fenomeno di “street style armato”: giovani, ex-combattenti, figli della borghesia, politicizzati e violenti.
Compiono spedizioni punitive, distruggono tipografie, incendiando sedi di partito e cooperative. Lo fanno protetti da grandi proprietari terrieri, industriali, apparati dello Stato, a cui offrono in cambio una protezione brutale contro il pericolo socialista.
Mussolini li userà finché torneranno utili, poi li ingloberà nello Stato.

Il nero: tra silenzio e minaccia
Un elemento ricorrente e fondamentale in questa estetica è il colore nero: le famigerate camicie nere, certo, ma anche l’intero immaginario cromatico che accompagna i simboli della repressione e della negazione.
Il nero non comunica: impone.
È il colore dell’assenza, della morte, della minaccia. È il colore dei pirati, dei preti, dei giudici. È anche il colore del potere e del feticismo. E proprio per questo, sarà riassorbito nella moda e nel cinema.
Pensiamo al “Portiere di notte” (1974) o ad “Arancia Meccanica”: in entrambi i casi, elementi dell’estetica fascista vengono ricontestualizzati in chiave ambigua, disturbante, erotico-violenta.
La nascita dell’uniforme squadrista
L’iconografia fascista non nasce dal nulla: eredita, ruba e muta simboli preesistenti.
Il guardaroba degli squadristi prende forma attingendo direttamente all’estetica degli Arditi, corpo speciale dell’esercito regio italiano nato nelle fasi finali della Prima Guerra Mondiale.
Gli Arditi erano giovani, spesso non sposati, selezionati per compiti estremi.
Erano uomini che vivevano costantemente a contatto con la morte, e che di quella morte fecero uno stile.
Da loro provengono alcuni degli elementi più sinistri dell’estetica fascista:
- Il teschio con pugnale tra i denti, ricamato su gagliardetti neri e camicie;
- Il motto “Me ne frego”, spesso scritto persino sulle bende insanguinate;
- Il saluto “A noi!” e la canzone “Giovinezza!”, entrati nel culto fascista ma originariamente parte dell’immaginario ardito.
Ogni dettaglio comunica minaccia, morte, esclusione. Il colore nero non è solo un colore: è strategia estetica.

Anche l’uniforme fascista prende forma dal vestiario degli Arditi
Il look squadrista è una composizione ibrida tra militarismo, provocazione borghese e riferimenti contadini.
- Giubba in panno da bersagliere ciclista, grigioverde, con colletto aperto (più “informale” rispetto a quello chiuso alla coreana dell’uniforme standard);
- Maglione nero o camicia verde con cravatta nera;
- Pantaloni grigioverde al ginocchio, con fasce mollettiere;
- Il fez nero, copricapo di origine ottomana, diventa simbolo d’élite e violenza.

Ma l’elemento più noto, e più iconico, resta la camicia nera.
Un indumento semplice, usato dai braccianti dell’Emilia-Romagna per non mostrare lo sporco dei campi. Mussolini la sceglie strategicamente per contrastare la camicia rossa garibaldina, riscrivendo l’immaginario nazionale.
Non era neppure facile da trovare: il tessuto nero era raro e associato a chiesa e pompe funebri.
Le varianti: il fascismo come spettacolo
A seconda del contesto o dell’intenzione, il look squadrista poteva cambiare:
- La giubba militare veniva sostituita da giacche doppiopetto borghesi;
- Le fasce mollettiere lasciavano il posto a calzettoni più moderni;
- Gli accessori “dandy” abbondavano: stivali, guanti bianchi, monocolo, frustino da cavallerizzo.
Persino l’acconciatura seguiva un canone preciso: capelli lunghi davanti, tirati all’indietro con cerchietto; pizzetto o barba alla moschettiera.
Ogni dettaglio serviva a comunicare virilità, autorità, devianza.
Un’estetica costruita per farsi notare e per imporsi.

Accessorio essenziale: il manganello
L’accessorio più riconoscibile — e terrificante — dell’abbigliamento squadrista era il manganello.
Non solo arma, ma simbolo di dominio. E nei rari casi in cui ne era vietato l’uso, gli squadristi usavano alternative creative:
- Tirapugni improvvisati con sacchetti di sabbia;
- Pugnali, coltelli e — come narrato in “M. Il figlio del secolo” di Antonio Scurati e nell’ottima messa in scena nella serie televisiva di Joe Wright — stoccafissi presi al mercato (un’idea di Italo Balbo).
Accanto al manganello, la bottiglia d’olio di ricino: strumento di umiliazione, tortura e spettacolo.
Il dolore, come l’estetica, era parte integrante del progetto.
L’eredità inquieta
Negli anni Sessanta e Settanta, la moda inizierà a riprendere — spesso senza consapevolezza — molti di questi codici: giacche militari, pantaloni cargo, stivali da cavallo, il nero come cifra di potere e silenzio.
E oggi, nelle sfilate di Prada, Loewe, Tom Ford (Prada e “La Zona d’Interesse”: quando moda e cinema raccontano la cecità del presente), assistiamo a una rilettura postmoderna dell’abbigliamento bellico e anche dall’estetica fascista.
Ma ogni citazione visiva, volente o nolente, porta con sé la memoria del corpo da cui nasce.